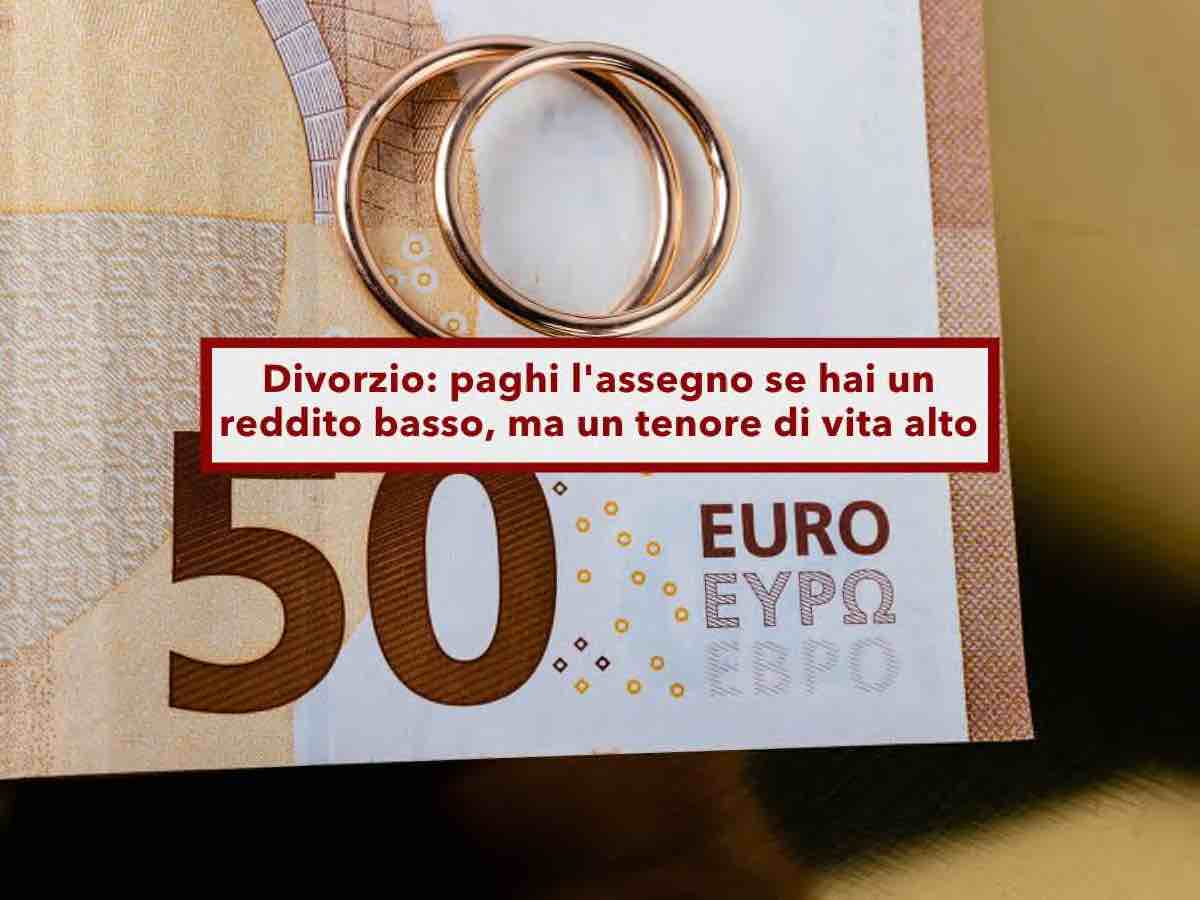La vicenda: dal Tribunale di Lodi alla Corte di Appello di Milano
Il procedimento trae origine dalla separazione e dal successivo divorzio tra due coniugi, A.A. e B.B., genitori di due figlie. In primo grado, il Tribunale di Lodi aveva previsto, a carico del padre, un assegno di mantenimento di 700 euro mensili, collegato alla rata del mutuo dell’abitazione familiare.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1017/2024, riformava parzialmente la decisione. Da un lato, rideterminava l’onere contributivo del padre, fissando un assegno perequativo di 450 euro mensili per la figlia minore C.C., con esclusione delle somme versate per l’altra figlia D.D., nel frattempo trasferitasi a vivere con lui. Dall’altro, poneva a carico della madre le spese condominiali e le utenze della casa familiare.
Il punto più controverso era la ricostruzione della reale situazione economica del padre. Sebbene il reddito dichiarato fosse estremamente basso (circa 1.000 euro annui), la Corte d’Appello aveva ritenuto che la sua capacità reddituale fosse molto più elevata, considerati gli esborsi sostenuti senza ricorrere a prestiti e la partecipazione societaria del 40% in un’azienda di famiglia.
Contro tale pronuncia, A.A. ricorreva in Cassazione, sollevando cinque motivi, tra cui la violazione delle regole sull’onere della prova e l’erronea valutazione delle presunzioni. A sua volta, B.B. proponeva ricorso incidentale, contestando in particolare la decorrenza dell’assegno e la ripartizione delle spese relative all’abitazione.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 25558, ha rigettato il ricorso principale dell’ex marito, ritenendo corretta la valutazione della Corte d’Appello in merito alla sua capacità economica effettiva. La Cassazione, condividendo un orientamento consolidato in materia, ha ribadito che le dichiarazioni fiscali non sono vincolanti ai fini della quantificazione degli assegni di mantenimento, trattandosi di atti aventi funzione tributaria. Il giudice di merito, pertanto, può fondare il proprio convincimento anche su presunzioni semplici e su elementi di fatto, come il tenore di vita, le spese sostenute e la partecipazione a compagini societarie.
A smascherare la reale disponibilità economica del padre-imprenditore è stata la Guardia di Finanza. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme gialle hanno mostrato un patrimonio e una capacità di spesa non compatibili con i redditi formalmente denunciati.
Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato queste risultanze investigative, considerandole prove determinanti. Nessuna violazione delle regole processuali sull’onere della prova, dunque, ma una valutazione fondata e coerente con le evidenze raccolte.
Altra questione riguarda l’uso degli utili societari per effettuare consistenti investimenti. Una strategia lecita sul piano aziendale, ma che ha l’effetto di ridurre artificialmente i profitti distribuibili ai soci e, di conseguenza, il reddito personale dichiarato. In realtà, come ha sottolineato la Cassazione, simili operazioni non cancellano né impoveriscono il patrimonio del genitore: spostano soltanto le risorse, mantenendo intatta la capacità economica effettiva.