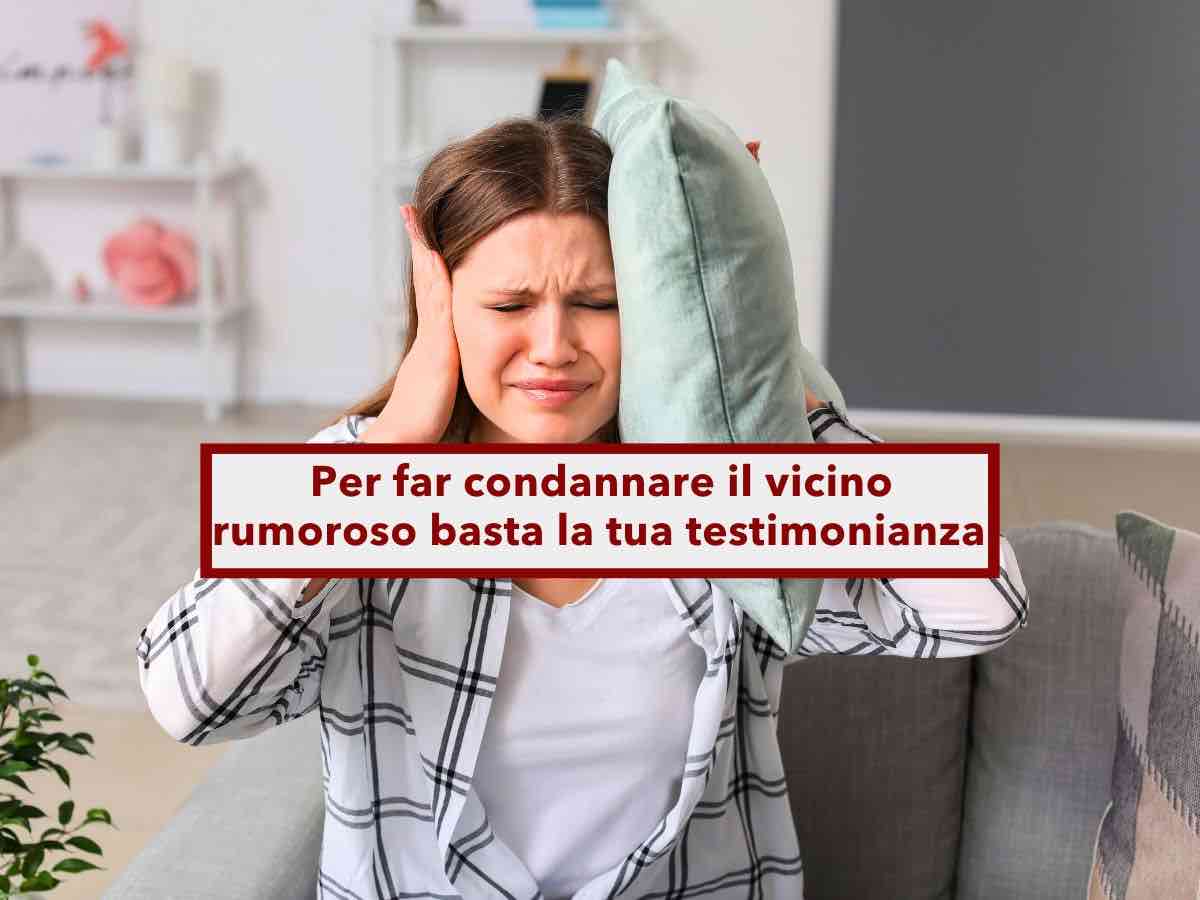Come è noto, nel nostro paese le liti in condominio costituiscono una larga fetta delle cause tra privati. L'uso scorretto delle parti comuni, i comportamenti che vìolano privacy o decoro, la gestione degli animali domestici sono solo alcuni esempi delle difficoltà di andare d'accordo con il vicino di casa. C'è poi il vasto capitolo degli schiamazzi e rumori molesti, una problematica che non passa mai di moda e su cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali nella sentenza n. 32043 del 26 settembre scorso, emessa dalla Terza Sezione penale.
In particolare, i giudici di piazza Cavour si sono pronunciati in merito alla configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica e sulle modalità di dimostrazione del fenomeno rumoroso. Di riferimento è il quadro normativo tracciato dall'art. 659 del c.p., testo che contempla una contravvenzione che può scaturire da condotte sia commissive (azioni dirette) sia omissive (inazioni), a patto che siano idonee a turbare le occupazioni o il recupero delle energie psicofisiche delle persone.
Ebbene, nella sentenza summenzionata, la Cassazione ha spiegato che - a seguito dell'evoluzione delle regole normative in tema di inquinamento acustico - il perimetro applicativo del citato articolo è stato progressivamente compresso, fino a racchiudere sostanzialmente i meri rapporti di vicinato e condominiali. E attenzione ai casi pratici in cui - effettivamente - la contravvenzione è integrata, perché secondo gli Ermellini:
In particolare, i giudici di piazza Cavour si sono pronunciati in merito alla configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica e sulle modalità di dimostrazione del fenomeno rumoroso. Di riferimento è il quadro normativo tracciato dall'art. 659 del c.p., testo che contempla una contravvenzione che può scaturire da condotte sia commissive (azioni dirette) sia omissive (inazioni), a patto che siano idonee a turbare le occupazioni o il recupero delle energie psicofisiche delle persone.
Ebbene, nella sentenza summenzionata, la Cassazione ha spiegato che - a seguito dell'evoluzione delle regole normative in tema di inquinamento acustico - il perimetro applicativo del citato articolo è stato progressivamente compresso, fino a racchiudere sostanzialmente i meri rapporti di vicinato e condominiali. E attenzione ai casi pratici in cui - effettivamente - la contravvenzione è integrata, perché secondo gli Ermellini:
- per configurare la contravvenzione non è obbligatorio che i rumori arrechino effettivo disturbo a più persone;
- è sufficiente, invece, che la condotta sia idonea a ledere quiete e occupazioni di una pluralità di soggetti, anche se soltanto uno di essi si lamenta.
A riprova di questo orientamento giurisprudenziale, c'è la precisazione per cui il bene giuridico tutelato non è il riposo di una persona specifica, ma la quiete pubblica e l'ordine pubblico, lesi da schiamazzi o rumori, dall'abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, oppure dagli strepiti di animali. Inoltre, come ha già indicato la Corte in passato (Cass. 18521/2018), al fine di integrare l'illecito penale ed essere responsabili ai sensi dell'art. 659 c.p., è necessario provare che i rumori abbiano - astrattamente - la capacità oggettiva di disturbare una platea indeterminata e consistente degli occupanti dell'edificio (tutti gli occupanti o una parte, oppure una parte del vicinato). La responsabilità penale scatta indipendentemente dal numero di persone che - in concreto - protestano, e a prescindere dal fatto che siano state realmente disturbate. Occorre, cioè, la dimostrazione della diffusività e della percettibilità delle emissioni sonore.
Nel caso affrontato e deciso dalla Corte con la sentenza suddetta, il giudice penale aveva condannato l'occupante di un'abitazione a un'ammenda per avere prodotto, prevalentemente nelle ore notturne, forti rumori e musica ad alto volume, impedendo agli abitanti dell'appartamento del piano di sotto di svolgere serenamente le attività quotidiane e riposare.
L'imputato si era difeso, impugnando la condanna e affermando che il disturbo riguardasse il mero appartamento sottostante, segnalando la mancanza di accertamenti tecnici sull'intensità delle immissioni sonore e la doverosità di verifiche di natura tecnico-specialistica. Ma la Cassazione, ribadendo la linea per cui la contravvenzione si configura quando la condotta sia astrattamente e oggettivamente idonea (Cass. 3823/1994 e 4820/1999) a determinare un disagio diffuso, collettivo e generalizzato, ha bocciato il ricorso e ha confermato la sentenza contestata.
Un punto molto importante della decisione n. 32043 dei giudici di piazza Cavour riguarda la tipologia di prova del fenomeno rumoroso. Sulla linea di una costante giurisprudenza (Cass. 1501/2018 e 20954/2011), la Cassazione spiega che non è obbligatorio disporre di una perizia fonometrica, perché il magistrato competente può basare i propri convincimenti e giungere alla decisione, tramite lo scrupoloso vaglio di elementi probatori di diversa natura, come ad esempio le testimonianze di vicini e i riscontri degli agenti intervenuti. In altre parole, l'analisi tecnica che misura il livello di rumore in un ambiente, per stabilire se i limiti di legge o di conformità sono rispettati, non è necessaria ai fini dell'accertamento della violazione della normale tollerabilità dei rumori.
Nel caso giunto alla sua attenzione, la Corte ha ritenuto sufficienti le deposizioni dei vicini e i rilievi notturni degli operanti, che avevano constatato musica ad alto volume e presenza di cani nelle scale del palazzo, a dimostrare l'idoneità oggettiva dei rumori a disturbare la quiete pubblica.
Ricapitolando, l'accertamento tecnico con perizia non è indispensabile, ma va da sé che, in caso di contestazioni sulla reale diffusività delle emissioni sonore, può essere opportuno disporre accertamenti tecnici specifici. In ogni caso, chi vive in condominio deve essere consapevole che anche rumori provenienti da un solo appartamento possono configurare il reato di disturbo della quiete pubblica, se astrattamente e oggettivamente idonei a turbare più persone. La sentenza n. 32043/2025 conferma quindi l'orientamento della Cassazione, offrendo chiarezza sul modo in cui giudici e cittadini devono interpretare le norme sui rumori molesti in ambito condominiale, e bilanciando il diritto al riposo con le esigenze della vita quotidiana.
Nel caso affrontato e deciso dalla Corte con la sentenza suddetta, il giudice penale aveva condannato l'occupante di un'abitazione a un'ammenda per avere prodotto, prevalentemente nelle ore notturne, forti rumori e musica ad alto volume, impedendo agli abitanti dell'appartamento del piano di sotto di svolgere serenamente le attività quotidiane e riposare.
L'imputato si era difeso, impugnando la condanna e affermando che il disturbo riguardasse il mero appartamento sottostante, segnalando la mancanza di accertamenti tecnici sull'intensità delle immissioni sonore e la doverosità di verifiche di natura tecnico-specialistica. Ma la Cassazione, ribadendo la linea per cui la contravvenzione si configura quando la condotta sia astrattamente e oggettivamente idonea (Cass. 3823/1994 e 4820/1999) a determinare un disagio diffuso, collettivo e generalizzato, ha bocciato il ricorso e ha confermato la sentenza contestata.
Un punto molto importante della decisione n. 32043 dei giudici di piazza Cavour riguarda la tipologia di prova del fenomeno rumoroso. Sulla linea di una costante giurisprudenza (Cass. 1501/2018 e 20954/2011), la Cassazione spiega che non è obbligatorio disporre di una perizia fonometrica, perché il magistrato competente può basare i propri convincimenti e giungere alla decisione, tramite lo scrupoloso vaglio di elementi probatori di diversa natura, come ad esempio le testimonianze di vicini e i riscontri degli agenti intervenuti. In altre parole, l'analisi tecnica che misura il livello di rumore in un ambiente, per stabilire se i limiti di legge o di conformità sono rispettati, non è necessaria ai fini dell'accertamento della violazione della normale tollerabilità dei rumori.
Nel caso giunto alla sua attenzione, la Corte ha ritenuto sufficienti le deposizioni dei vicini e i rilievi notturni degli operanti, che avevano constatato musica ad alto volume e presenza di cani nelle scale del palazzo, a dimostrare l'idoneità oggettiva dei rumori a disturbare la quiete pubblica.
Ricapitolando, l'accertamento tecnico con perizia non è indispensabile, ma va da sé che, in caso di contestazioni sulla reale diffusività delle emissioni sonore, può essere opportuno disporre accertamenti tecnici specifici. In ogni caso, chi vive in condominio deve essere consapevole che anche rumori provenienti da un solo appartamento possono configurare il reato di disturbo della quiete pubblica, se astrattamente e oggettivamente idonei a turbare più persone. La sentenza n. 32043/2025 conferma quindi l'orientamento della Cassazione, offrendo chiarezza sul modo in cui giudici e cittadini devono interpretare le norme sui rumori molesti in ambito condominiale, e bilanciando il diritto al riposo con le esigenze della vita quotidiana.