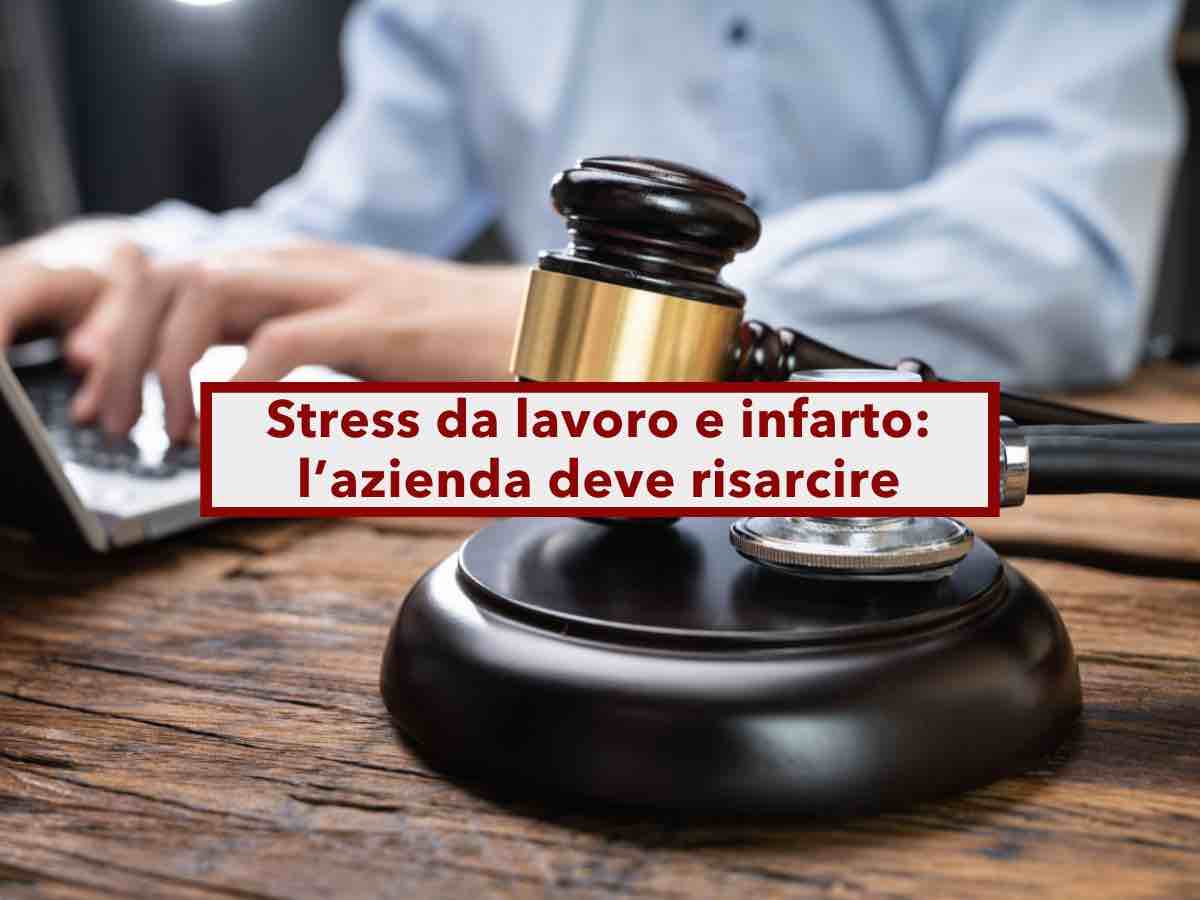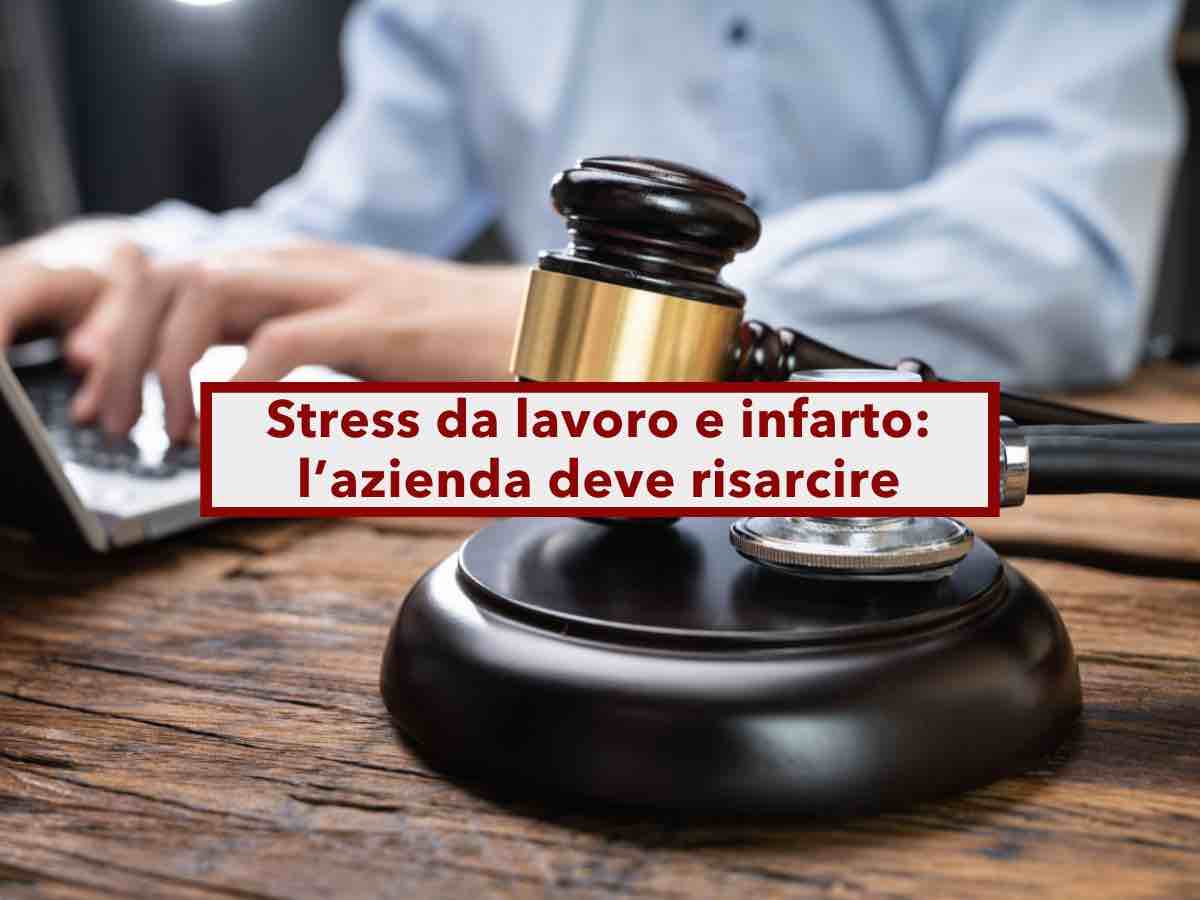Con l'ordinanza 26923 del 7 ottobre 2025, la sezione Lavoro della Suprema Corte ha stabilito un principio destinato a fare scuola: quando un lavoratore subisce un danno grave alla salute a causa dello stress lavorativo, non è lui a dover dimostrare tutte le responsabilità dell'azienda, ma è l'azienda stessa a dover provare la propria innocenza.
La dimostrazione dell’esistenza del
nesso causale tra le condizioni di lavoro e il danno subìto spetta, prima di tutto, al dipendente o ai suoi familiari. Questo collegamento non deve necessariamente derivare da un singolo episodio drammatico, ma può essere il risultato dell'
accumulo di situazioni stressanti nel tempo, quello che i giudici definiscono l'"
intero atteggiarsi del rapporto di lavoro". Una volta che questo legame viene provato, si verifica quella che - nel linguaggio giuridico - si chiama
inversione dell'onere probatorio: da questo momento in poi, tocca al
datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per proteggere la salute del proprio dipendente. In caso contrario, l'azienda è chiamata a rispondere del danno e a risarcire gli eredi della vittima.
Il caso esaminato dalla Cassazione: turni massacranti di un medico e infarto fatale
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda la
morte di un medico, stroncato da un infarto che i suoi familiari hanno collegato alle condizioni estreme in cui era costretto a lavorare. Gli elementi raccolti durante il
processo hanno dipinto un quadro allarmante: turni altamente stressanti, ritmi insostenibili e una pressione costante che avrebbero logorato progressivamente la salute del professionista. A rafforzare la tesi dei familiari c'era un elemento di peso: il riconoscimento dell'equo
indennizzo per causa di servizio, che in un'altra sede aveva già stabilito un collegamento tra l'attività lavorativa e il decesso.
La
Corte territoriale aveva inizialmente respinto le richieste dei familiari, sostenendo che non fosse stato dimostrato a sufficienza il nesso tra il lavoro e l'infarto. Ma la Cassazione ha censurato questa decisione con fermezza, sottolineando un errore di valutazione fondamentale: i giudici di merito avevano ignorato prove decisive come l'
assenza di patologie pregresse nel medico e, soprattutto, la
documentata esistenza di condizioni lavorative estreme. Secondo gli Ermellini, una volta dimostrato il
collegamento tra stress lavorativo e infarto, il tribunale avrebbe dovuto spostare l'attenzione sulla condotta del datore di lavoro, verificando se l'azienda avesse rispettato l'
obbligo contrattuale di tutelare l'integrità fisica del dipendente. L'inversione dell'
onere della prova non era stata applicata correttamente, impedendo una valutazione completa del caso.
Non solo danni fisici: il riconoscimento della sofferenza interiore
La sentenza del 7 ottobre 2025 si inserisce in un percorso giurisprudenziale sempre più orientato a proteggere i lavoratori dalle conseguenze dello stress professionale. Un precedente fondamentale risale al 24 agosto 2023 quando, con l’ordinanza n. 25191, la Cassazione si era pronunciata sul caso di un autista di autobus colpito da infarto dopo anni di turni pesanti, carichi eccessivi e orari impossibili da sostenere. In quella circostanza, l'uomo era diventato completamente inabile al lavoro dopo un intervento di triplo bypass coronarico, e i giudici avevano stabilito che aveva diritto al risarcimento non solo per il danno alla salute fisica, ma anche per il danno morale.
La Suprema Corte aveva spiegato come sarebbe stato difficile negare che una persona in quelle condizioni avesse sperimentato sofferenze profonde, paure per il proprio futuro e turbamenti emotivi. Il danno morale, inteso come la sofferenza interiore che accompagna una perdita così grave, rappresenta una componente autonoma e deve essere liquidato separatamente. Questa visione allarga notevolmente la sfera di tutela del lavoratore: non si tratta più soltanto di riparare il danno economico o quello strettamente fisico, ma di riconoscere l'impatto psicologico ed emotivo che una malattia professionale comporta per chi la subisce e per i suoi familiari.
Il lavoro come diritto costituzionale: dignità e realizzazione personale
La sentenza del 2023 aveva introdotto un altro concetto di straordinaria importanza, ripreso e rafforzato dalla decisione attuale: il lavoro non è soltanto un mezzo per guadagnarsi da vivere, ma rappresenta un valore costituzionale poliedrico. La Costituzione italiana tutela il lavoro sotto molteplici aspetti: quello economico certamente, ma anche quello legato alla dignità personale, alla partecipazione alla vita sociale e alla realizzazione individuale.
I giudici della Cassazione avevano sottolineato come il lavoro sia "
inseparabile dall'essere umano che lo presta". Quando un lavoratore viene privato della possibilità di svolgere la propria professione a causa di un comportamento illecito del datore di lavoro, non perde solo uno stipendio o la capacità fisica di compiere determinate mansioni. Perde una parte fondamentale della propria identità, della propria
utilità sociale, del proprio ruolo nella comunità.
Questi sono valori di pregnanza costituzionale che i tribunali devono considerare quando stabiliscono l'entità del risarcimento. La decisione del 7 ottobre 2025 conferma e rafforza questo principio, imponendo alle aziende un livello di diligenza massimo nella
protezione del benessere psico-fisico dei propri dipendenti. Il messaggio è chiaro: tutelare la salute dei lavoratori non è più solo un obbligo contrattuale, ma un imperativo che affonda le radici nei valori fondamentali della nostra democrazia.