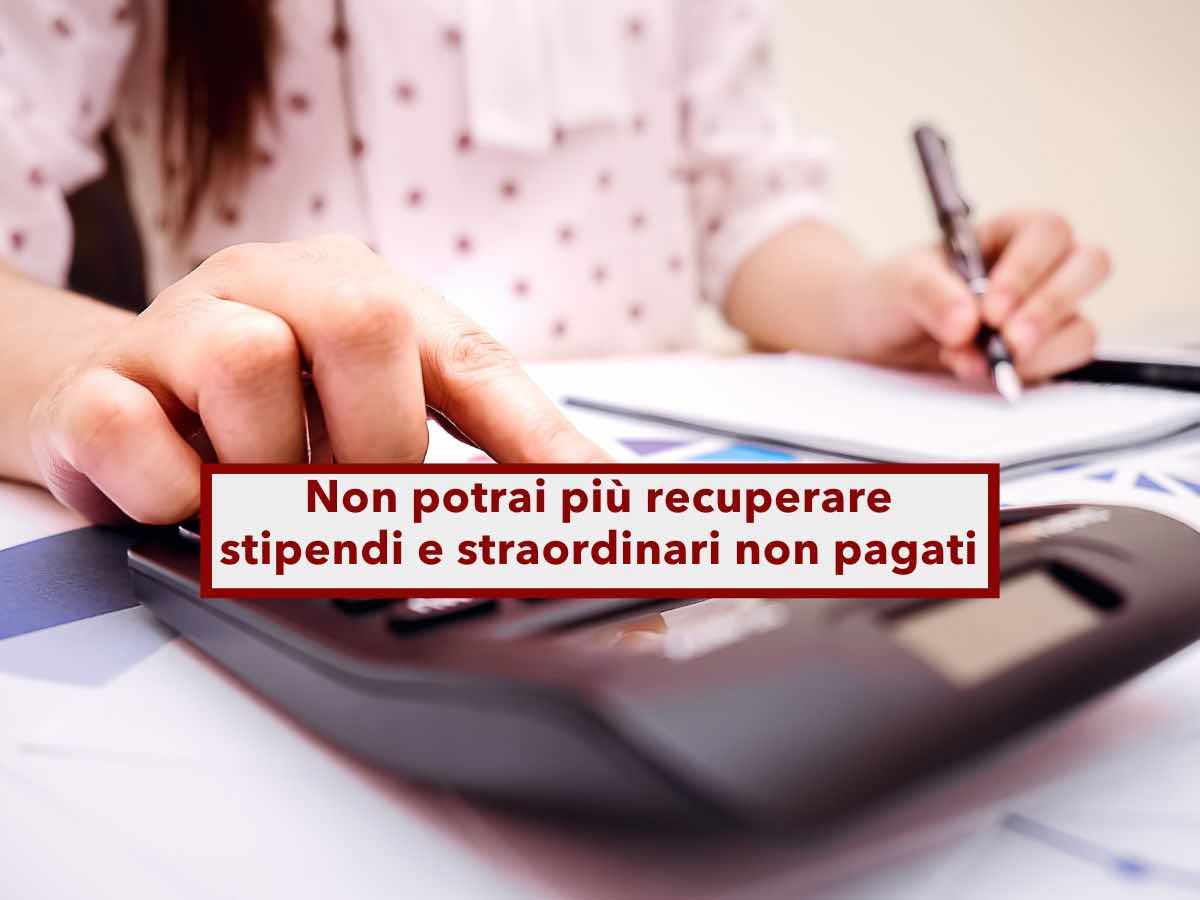Per oltre cinquant’anni, il principio è stato chiaro e giusto: la
prescrizione dei crediti da lavoro (stipendi, straordinari, differenze retributive) iniziava a decorrere solo dopo la fine del rapporto lavorativo. A stabilirlo era la giurisprudenza, fondata sull’evidente asimmetria di potere tra datore e dipendente. La
Corte Costituzionale ha più volte ribadito che un lavoratore, durante l’impiego, non è in una posizione di libertà tale da agire serenamente contro il proprio datore, perché teme licenziamenti, ritorsioni o peggioramenti delle condizioni lavorative. È il cosiddetto
metus, ovvero un
timore psicologico legittimo e riconosciuto anche in sede giudiziaria.
Ma l’
emendamento al decreto ex Ilva firmato dal senatore
Salvo Pogliese (
Fratelli d’Italia) ribalta tutto questo.
Prevede che la prescrizione dei crediti scatti anche mentre il lavoratore è ancora in servizio, ma solo se l’azienda ha più di 15 dipendenti. Una modifica che
mina la capacità concreta di far valere i propri diritti: se un dipendente riceve un inquadramento errato o una paga inferiore ai minimi contrattuali, avrà
soltanto cinque anni di tempo per agire, a partire dal mese successivo a quello in cui è nato il credito. Scaduto quel termine, non potrà più reclamare nulla, anche se continua a lavorare per lo stesso datore.
La norma ignora la realtà quotidiana delle fabbriche, degli uffici, dei negozi. Chi ha un mutuo, una famiglia, un lavoro precario non fa causa al capo a cuor leggero. E questa “riforma” lo sa bene: non tutela l’equilibrio tra le parti, ma legalizza la paura del lavoratore, trasformandola in un ostacolo insormontabile.
180 giorni per agire in tribunale: la ghigliottina sulla giustizia
Come se non bastasse, l’emendamento inserisce una seconda tagliola: una volta che il lavoratore ha inviato una lettera di diffida - un atto fondamentale per interrompere la prescrizione - ha solo 180 giorni (sei mesi) per depositare ricorso in tribunale. Se non lo fa, il suo diritto si estingue, in modo definitivo e irrevocabile.
Questa norma non lascia spazio a trattative, mediazioni o soluzioni extragiudiziali. Costringe il lavoratore a scegliere tra due alternative entrambe pericolose: o rinuncia a far valere i propri diritti, oppure deve affrontare subito una causa legale, con tutto ciò che comporta in termini di stress, costi e rischi.
Nella pratica, il risultato sarà devastante: molti dipendenti preferiranno non fare nulla, per paura di ritorsioni o per l’impossibilità economica di affrontare una causa entro tempi così stretti. Inoltre, la norma aumenterà il contenzioso, invece di ridurlo: costringe chi vuole solo difendere un diritto a fare causa, anche quando sarebbe stato possibile risolvere tutto con una semplice trattativa. È una follia giuridica che stravolge i principi di equità e proporzionalità, a vantaggio esclusivo dei datori di lavoro.
Eppure, secondo la nostra Costituzione, l’accesso alla giustizia deve essere garantito a tutti, come stabilito dall’
art. 24 Cost.. Questa norma, invece, lo rende un lusso per pochi, limitando nei fatti il diritto alla difesa.
Condono sulle paghe da fame: come cancellare anni di ingiustizie salariali
Ma la parte più cinica dell’emendamento arriva con la
sanatoria per le retribuzioni da fame, quella che colpisce direttamente l’
art. 36 Cost., dove si afferma che “
il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
Finora, chi riceveva una paga troppo bassa - perché legato a un contratto “pirata” o sottopagato rispetto al minimo di settore - poteva rivolgersi al giudice e ottenere un risarcimento anche per gli anni passati. Bastava dimostrare l’inadeguatezza della
retribuzione, e il datore di lavoro veniva condannato a versare gli arretrati.
Con il nuovo emendamento, invece, quel diritto svanisce. La norma stabilisce due cose gravissime:
-
se il contratto collettivo è firmato dai sindacati “comparativamente più rappresentativi”, la sua retribuzione si presume automaticamente sufficiente, anche se nella realtà è troppo bassa;
-
se un giudice, dopo anni di lavoro sottopagato, accerta che il salario era inferiore al minimo costituzionale, non potrà più condannare il datore a pagare gli arretrati. L’adeguamento salariale scatterà solo dal giorno in cui il lavoratore ha presentato la richiesta in tribunale, cancellando ogni possibilità di recuperare quanto dovuto per il passato.
È un vero e proprio condono per chi ha violato la Costituzione, una sanatoria che premia l’illegalità salariale, trasformando l’ingiustizia in una prassi tollerata. In pratica, lo Stato dice: “Se hai pagato una miseria ai tuoi dipendenti per anni, stai tranquillo. Non ti succederà nulla.”
Una riforma incostituzionale, infilata di nascosto: così si aggira la democrazia
Oltre al contenuto devastante per i diritti dei lavoratori, il metodo con cui è stato introdotto l’emendamento è altrettanto grave. Si tratta infatti di una modifica profonda al diritto del lavoro, che cambia regole fondamentali sulla prescrizione, la retribuzione e il contenzioso. Ma, invece di presentarla come una legge autonoma, con discussione in aula e confronto con le parti sociali, è stata nascosta dentro un decreto-legge sull’ex Ilva. Un tema tecnico e specifico - la salvezza dell’industria siderurgica - usato come copertura per fare passare una riforma impopolare e pericolosa.
È la tipica “legislazione omnibus”, più volte bocciata dalla Corte Costituzionale, perché viola il principio di omogeneità previsto per le leggi di conversione. Le norme inserite devono essere coerenti con l’oggetto del decreto originario. Qui, evidentemente, non lo sono affatto.
In questo modo, si aggira la democrazia parlamentare e si impedisce un dibattito pubblico sul tema. Ma la forzatura potrebbe ritorcersi contro i suoi autori: il
Presidente della Repubblica potrebbe segnalare l’irregolarità, e la Corte Costituzionale potrebbe annullare l’intero impianto normativo, per violazione dell’
art. 3 Cost., dell’
art. 24 Cost. e dell’
art. 36 Cost..