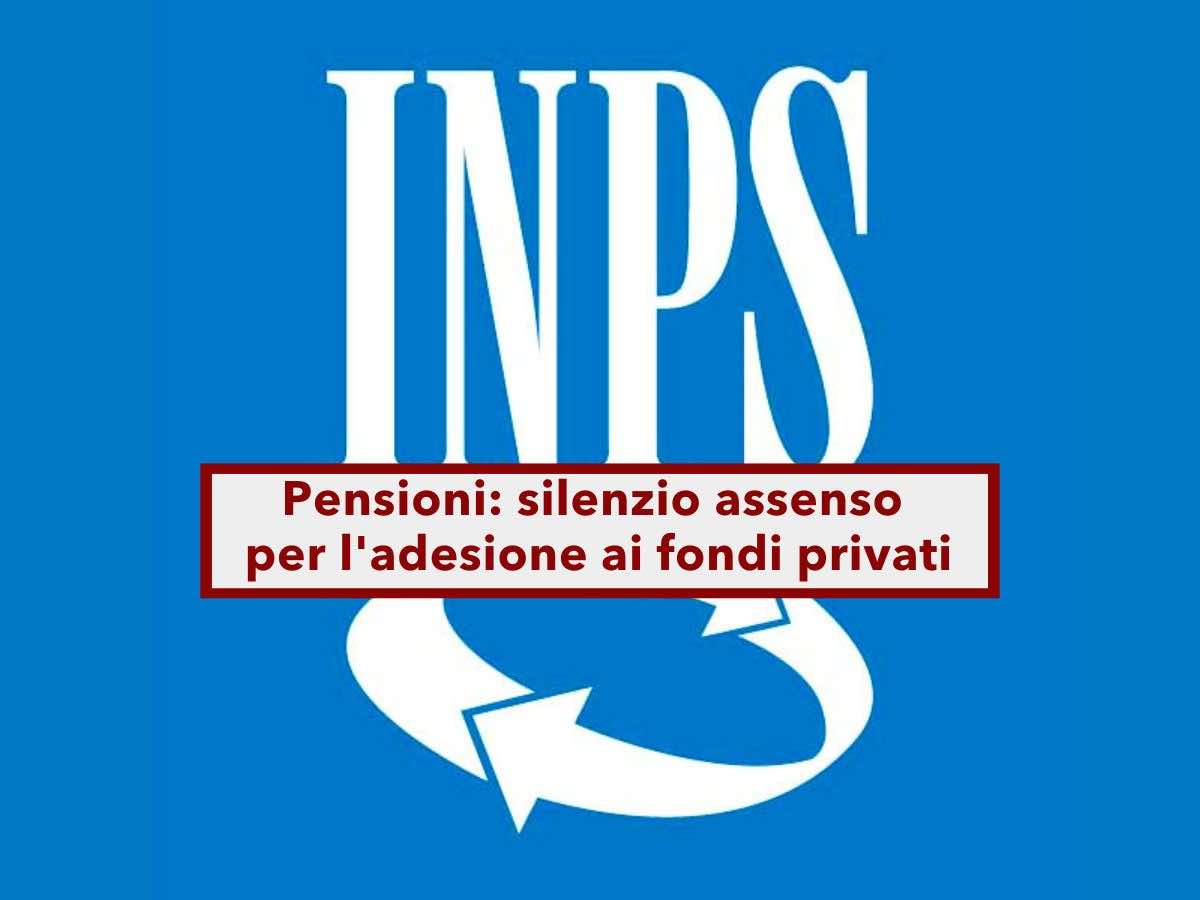Lo Stato sta riconoscendo, nei fatti, l'insostenibilità del sistema pensionistico pubblico sul lungo termine; ci sono alcuni significativi segnali dell'intenzione di spostare - almeno in parte - l'onere della sicurezza previdenziale dal pubblico al privato, ossia dalla dimensione collettiva a quella individuale. Il sistema pubblico, oggi basato sul principio della ripartizione (i contributi dei lavoratori attivi finanziano le pensioni correnti), risulta sempre più in difficoltà a causa del cosiddetto "inverno demografico" e, proprio per questo, l'attuale Esecutivo sta valutando di introdurre il meccanismo del silenzio-assenso per l'adesione ai fondi pensione integrativi o complementari, ossia quegli strumenti finanziari creati per integrare la pensione pubblica obbligatoria, versata dall'Inps. Queste sono alcune delle ultime indiscrezioni che giungono dagli ambienti governativi.
Sostanzialmente, per rinunciare alla tutela del secondo pilastro pensionistico, il dipendente dovrebbe espressamente e formalmente opporsi all'iscrizione ai fondi in oggetto (a cui ha aderito il datore di lavoro). L'iscrizione - da opzionale - diventerebbe cioè automatica, appunto per silenzio-assenso. In altre parole, la non adesione sarebbe la scelta attiva del dipendente, e non più il contrario come invece è oggi.
Con tale meccanismo, e con l'inevitabile interlocuzione con l'articolato mondo assicurativo, il Governo mira a trovare una soluzione, almeno parziale, al problema della tenuta del sistema pensionistico pubblico nel suo complesso. La popolazione invecchia, i giovani diminuiscono e le pensioni ordinarie, basate sul metodo contributivo, non sono in grado di garantire sicurezza economica e potere d'acquisto, negli anni successivi alla fine della carriera.
Per questo, dalle istituzioni l'accesso "predefinito" al sistema pensionistico privato è visto come un'ancora di salvezza per le entrate mensili dei pensionati dei prossimi decenni e, al contempo, la proposta della previdenza complementare per silenzio-assenso potrebbe combinarsi con alcune proposte che giungono direttamente dall'interlocutore assicurativo. Si pensi, ad esempio, all'adattamento automatico della strategia d'investimento all'età dell'aderente, all'aumento del limite di deducibilità fiscale, per rendere più conveniente versare importi maggiori, oppure alla possibilità che i familiari più stretti contribuiscano personalmente ai versamenti nei fondi pensione di figli o nipoti, beneficiando delle agevolazioni fiscali. Se, da un lato, queste misure rispondono all'esigenza dello Stato di alleggerire il peso della spesa pensionistica pubblica, dall'altro delineano nuovi spazi di espansione e profitto per il settore assicurativo, sempre più centrale nella costruzione del “welfare individuale”.
Ecco perché non sorprende che, al contempo, le istituzioni intendano creare una sorta di "paracadute" costituito da specifiche polizze assicurative contro il rischio di cadere nella non autosufficienza. Oggi l'assistenza nei confronti di chi si trova in questa condizione - che include badanti, strutture residenziali, ausili e cure sanitarie - comporta costi molto elevati, che gravano in larga parte sulle famiglie, mentre il sistema sanitario pubblico, già fortemente sotto pressione, fatica a garantire risposte adeguate.
Per far fronte a questa emergenza crescente, si guarda con attenzione ad alcuni modelli europei che prevedono la diffusione di polizze assicurative per la long-term care, ovvero la cura e l'assistenza di lungo periodo in caso di perdita dell'autosufficienza. Il meccanismo è semplice: durante la vita lavorativa, il cittadino versa un premio annuale di importo contenuto - qualche centinaio di euro all'anno - possibilmente co-finanziato dal datore di lavoro e agevolato fiscalmente. In cambio, nel caso in cui da anziano perda la capacità di svolgere in autonomia le attività quotidiane, potrà accedere a una rendita mensile oppure a servizi di assistenza convenzionati e controllati, finanziati dalla compagnia assicurativa stessa.
Concludendo, anche in questo caso la volontà delle istituzioni, in sinergia con il mondo assicurativo, è spingere fortemente all'adesione da parte del singolo, al fine di decentralizzare la responsabilità assistenziale, puntando su strumenti assicurativi individuali per affrontare uno dei problemi sociali più rilevanti del prossimo futuro.
Sostanzialmente, per rinunciare alla tutela del secondo pilastro pensionistico, il dipendente dovrebbe espressamente e formalmente opporsi all'iscrizione ai fondi in oggetto (a cui ha aderito il datore di lavoro). L'iscrizione - da opzionale - diventerebbe cioè automatica, appunto per silenzio-assenso. In altre parole, la non adesione sarebbe la scelta attiva del dipendente, e non più il contrario come invece è oggi.
Con tale meccanismo, e con l'inevitabile interlocuzione con l'articolato mondo assicurativo, il Governo mira a trovare una soluzione, almeno parziale, al problema della tenuta del sistema pensionistico pubblico nel suo complesso. La popolazione invecchia, i giovani diminuiscono e le pensioni ordinarie, basate sul metodo contributivo, non sono in grado di garantire sicurezza economica e potere d'acquisto, negli anni successivi alla fine della carriera.
Per questo, dalle istituzioni l'accesso "predefinito" al sistema pensionistico privato è visto come un'ancora di salvezza per le entrate mensili dei pensionati dei prossimi decenni e, al contempo, la proposta della previdenza complementare per silenzio-assenso potrebbe combinarsi con alcune proposte che giungono direttamente dall'interlocutore assicurativo. Si pensi, ad esempio, all'adattamento automatico della strategia d'investimento all'età dell'aderente, all'aumento del limite di deducibilità fiscale, per rendere più conveniente versare importi maggiori, oppure alla possibilità che i familiari più stretti contribuiscano personalmente ai versamenti nei fondi pensione di figli o nipoti, beneficiando delle agevolazioni fiscali. Se, da un lato, queste misure rispondono all'esigenza dello Stato di alleggerire il peso della spesa pensionistica pubblica, dall'altro delineano nuovi spazi di espansione e profitto per il settore assicurativo, sempre più centrale nella costruzione del “welfare individuale”.
Ecco perché non sorprende che, al contempo, le istituzioni intendano creare una sorta di "paracadute" costituito da specifiche polizze assicurative contro il rischio di cadere nella non autosufficienza. Oggi l'assistenza nei confronti di chi si trova in questa condizione - che include badanti, strutture residenziali, ausili e cure sanitarie - comporta costi molto elevati, che gravano in larga parte sulle famiglie, mentre il sistema sanitario pubblico, già fortemente sotto pressione, fatica a garantire risposte adeguate.
Per far fronte a questa emergenza crescente, si guarda con attenzione ad alcuni modelli europei che prevedono la diffusione di polizze assicurative per la long-term care, ovvero la cura e l'assistenza di lungo periodo in caso di perdita dell'autosufficienza. Il meccanismo è semplice: durante la vita lavorativa, il cittadino versa un premio annuale di importo contenuto - qualche centinaio di euro all'anno - possibilmente co-finanziato dal datore di lavoro e agevolato fiscalmente. In cambio, nel caso in cui da anziano perda la capacità di svolgere in autonomia le attività quotidiane, potrà accedere a una rendita mensile oppure a servizi di assistenza convenzionati e controllati, finanziati dalla compagnia assicurativa stessa.
Concludendo, anche in questo caso la volontà delle istituzioni, in sinergia con il mondo assicurativo, è spingere fortemente all'adesione da parte del singolo, al fine di decentralizzare la responsabilità assistenziale, puntando su strumenti assicurativi individuali per affrontare uno dei problemi sociali più rilevanti del prossimo futuro.