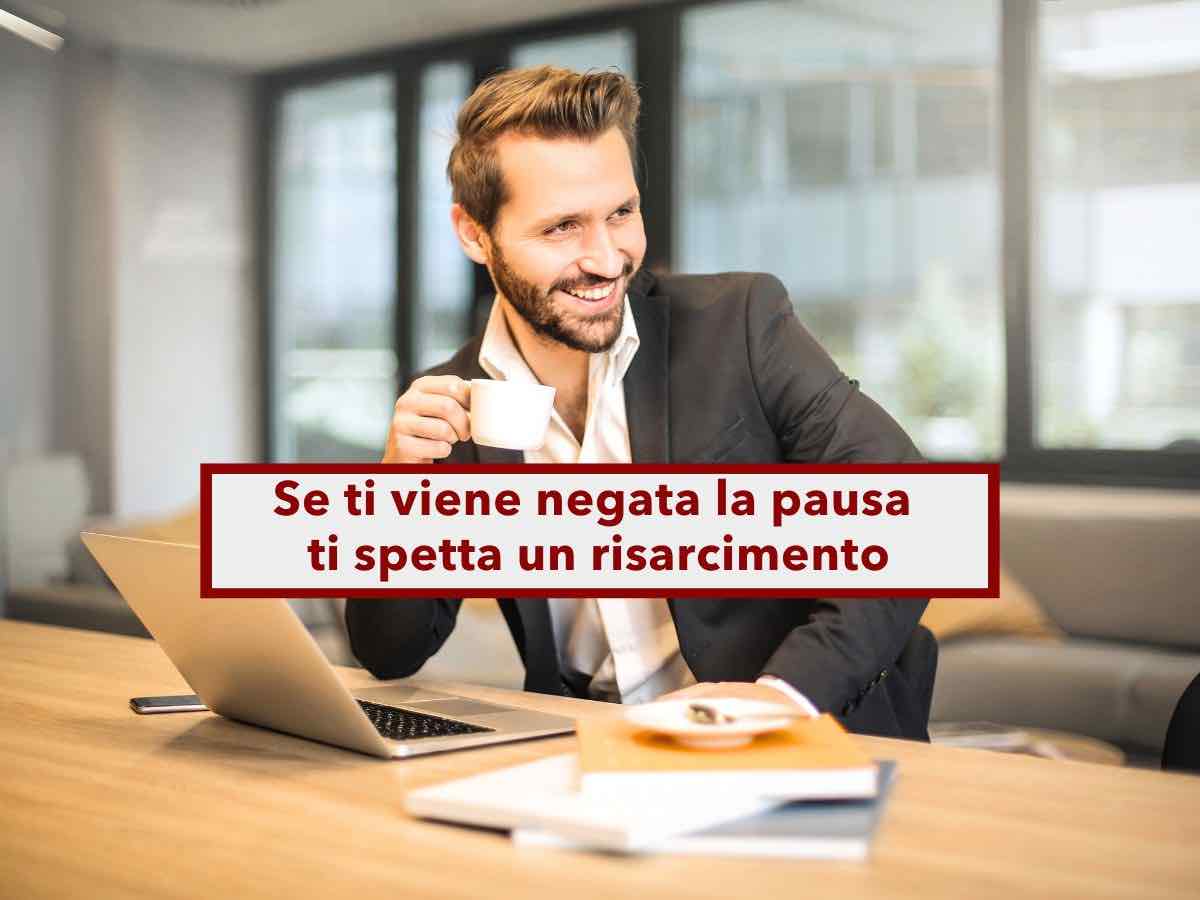Le giornate di lavoro possono essere spesso intense, faticose e cariche di responsabilità. Che si tratti di turni in ambito sanitario, come nel caso degli operatori del 118, o di altri contesti professionali, il ritmo serrato e la pressione costante possono mettere a dura prova l’equilibrio psico-fisico dei lavoratori. In questo scenario, le pause durante il turno non rappresentano un semplice diritto formale, ma una necessità concreta per tutelare la salute, garantire la concentrazione e prevenire situazioni di stress o affaticamento cronico. Non a caso, la normativa italiana ed europea impone ai datori di lavoro il rispetto di determinati tempi di pausa, proprio per evitare che il lavoro si trasformi in un fattore di rischio per il benessere psicofisico delle persone.
Il caposaldo della normativa italiana sulle pause lavorative è rappresentato dall'articolo 8 del D.Lgs. 66/2003, che stabilisce un principio fondamentale: qualsiasi lavoratore ha diritto a interrompere l'attività per almeno 10 minuti consecutivi quando l'orario giornaliero supera le 6 ore continuative.
Questa pausa rappresenta un diritto irrinunciabile del dipendente e la sua finalità primaria è il recupero psicofisico del lavoratore, contribuendo alla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
Le modalità e la durata dell’intervallo per la pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro o dai regolamenti aziendali. Se manca una disciplina collettiva, comunque al lavoratore deve essere riconosciuta una pausa di almeno 10 minuti.
Questa pausa può essere utilizzata dal lavoratore nel modo che preferisce. È il Ministero del Lavoro a precisarlo (con la circolare n. 8 del 2005). Quindi, ad esempio, il dipendente può usufruire dei suoi 10 minuti di intervallo per prendere un caffè, andare in bagno, consumare un pasto oppure fumare una sigaretta.
Come confermato da diverse sentenze della Cassazione (si cita, ad esempio, l'ordinanza n. 12504/2025), questa pausa non può essere negata o limitata dal datore di lavoro, costituendo un elemento essenziale per il benessere del lavoratore. In pratica, il datore potrà vietare ai propri dipendenti di fare una pausa soltanto quando l’intervallo superi il periodo di tempo stabilito nel contratto collettivo o nel regolamento aziendale o, in mancanza di disciplina, quando comunque vengano superati i 10 minuti.
Anche la sospensione temporanea dell'attività per fumare una sigaretta rientra tra le interruzioni consentite nell'ambito delle norme generali sulle pause. Tuttavia, è imprescindibile rispettare le disposizioni interne aziendali sul fumo e la legislazione nazionale in materia. In assenza di aree specificatamente dedicate ai fumatori all'interno della struttura, è obbligatorio recarsi all'esterno dell'edificio per fumare, come stabilito dalla normativa antifumo (L. n. 3 del 2003). Questo spostamento deve avvenire in tempi ragionevoli e non eccessivamente dispendiosi.
Vale la pena anche di precisare che dalla regolamentazione standard sulle pause sono escluse diverse categorie professionali: telelavoratori e lavoratori a domicilio; dirigenti e personale con funzioni direttive; soggetti con autonomo potere decisionale; lavoratori mobili e collaboratori familiari. Per queste figure professionali, non esistendo un orario di lavoro rigidamente prestabilito, anche le pause seguono logiche differenti.
Adesso, con l’ordinanza n. 20249 del 2025, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto di grande rilevanza: la sistematica violazione dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003 può comportare un danno da usura psicofisica per il lavoratore; tale danno - secondo la Suprema Corte - può essere riconosciuto anche in assenza di una prova diretta, basandosi su presunzioni fondate.
La vicenda
Il caso riguarda alcuni dipendenti dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118, i quali hanno impugnato in appello la sentenza n. 501/2021 del Tribunale di Velletri. Tale sentenza aveva riconosciuto solo il diritto alla pausa giornaliera minima di 10 minuti per ogni turno superiore a sei ore, a partire da dicembre 2008, senza però accogliere la richiesta di risarcimento per il danno da usura psicofisica.
I lavoratori, ritenendo che la sistematica mancata fruizione delle pause avesse compromesso la loro salute psico-fisica, hanno presentato appello. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1842/2023, ha dato loro ragione, condannando l’Azienda al risarcimento del danno subito.
Il principio affermato dalla Cassazione: non c’è danno “in re ipsa”, ma la lesione è presunta
La Cassazione ha confermato l’orientamento della Corte d’Appello, precisando che la violazione delle norme sulle pause può effettivamente arrecare un danno ai lavoratori, anche se non automaticamente. Non si tratta di un danno “in re ipsa” (ossia presumibile in via automatica), ma di una lesione che il giudice può riconoscere in via presuntiva, valutando la gravità dell’inadempimento e la sua incidenza sulle condizioni di lavoro.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ripetuta mancata concessione delle pause, protrattasi per anni, sia sufficiente a far presumere un danno significativo alla sfera psico-fisica dei dipendenti, anche in assenza di prove mediche dirette.
Il caposaldo della normativa italiana sulle pause lavorative è rappresentato dall'articolo 8 del D.Lgs. 66/2003, che stabilisce un principio fondamentale: qualsiasi lavoratore ha diritto a interrompere l'attività per almeno 10 minuti consecutivi quando l'orario giornaliero supera le 6 ore continuative.
Questa pausa rappresenta un diritto irrinunciabile del dipendente e la sua finalità primaria è il recupero psicofisico del lavoratore, contribuendo alla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.
Le modalità e la durata dell’intervallo per la pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro o dai regolamenti aziendali. Se manca una disciplina collettiva, comunque al lavoratore deve essere riconosciuta una pausa di almeno 10 minuti.
Questa pausa può essere utilizzata dal lavoratore nel modo che preferisce. È il Ministero del Lavoro a precisarlo (con la circolare n. 8 del 2005). Quindi, ad esempio, il dipendente può usufruire dei suoi 10 minuti di intervallo per prendere un caffè, andare in bagno, consumare un pasto oppure fumare una sigaretta.
Come confermato da diverse sentenze della Cassazione (si cita, ad esempio, l'ordinanza n. 12504/2025), questa pausa non può essere negata o limitata dal datore di lavoro, costituendo un elemento essenziale per il benessere del lavoratore. In pratica, il datore potrà vietare ai propri dipendenti di fare una pausa soltanto quando l’intervallo superi il periodo di tempo stabilito nel contratto collettivo o nel regolamento aziendale o, in mancanza di disciplina, quando comunque vengano superati i 10 minuti.
Anche la sospensione temporanea dell'attività per fumare una sigaretta rientra tra le interruzioni consentite nell'ambito delle norme generali sulle pause. Tuttavia, è imprescindibile rispettare le disposizioni interne aziendali sul fumo e la legislazione nazionale in materia. In assenza di aree specificatamente dedicate ai fumatori all'interno della struttura, è obbligatorio recarsi all'esterno dell'edificio per fumare, come stabilito dalla normativa antifumo (L. n. 3 del 2003). Questo spostamento deve avvenire in tempi ragionevoli e non eccessivamente dispendiosi.
Vale la pena anche di precisare che dalla regolamentazione standard sulle pause sono escluse diverse categorie professionali: telelavoratori e lavoratori a domicilio; dirigenti e personale con funzioni direttive; soggetti con autonomo potere decisionale; lavoratori mobili e collaboratori familiari. Per queste figure professionali, non esistendo un orario di lavoro rigidamente prestabilito, anche le pause seguono logiche differenti.
Adesso, con l’ordinanza n. 20249 del 2025, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto di grande rilevanza: la sistematica violazione dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003 può comportare un danno da usura psicofisica per il lavoratore; tale danno - secondo la Suprema Corte - può essere riconosciuto anche in assenza di una prova diretta, basandosi su presunzioni fondate.
La vicenda
Il caso riguarda alcuni dipendenti dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118, i quali hanno impugnato in appello la sentenza n. 501/2021 del Tribunale di Velletri. Tale sentenza aveva riconosciuto solo il diritto alla pausa giornaliera minima di 10 minuti per ogni turno superiore a sei ore, a partire da dicembre 2008, senza però accogliere la richiesta di risarcimento per il danno da usura psicofisica.
I lavoratori, ritenendo che la sistematica mancata fruizione delle pause avesse compromesso la loro salute psico-fisica, hanno presentato appello. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1842/2023, ha dato loro ragione, condannando l’Azienda al risarcimento del danno subito.
Il principio affermato dalla Cassazione: non c’è danno “in re ipsa”, ma la lesione è presunta
La Cassazione ha confermato l’orientamento della Corte d’Appello, precisando che la violazione delle norme sulle pause può effettivamente arrecare un danno ai lavoratori, anche se non automaticamente. Non si tratta di un danno “in re ipsa” (ossia presumibile in via automatica), ma di una lesione che il giudice può riconoscere in via presuntiva, valutando la gravità dell’inadempimento e la sua incidenza sulle condizioni di lavoro.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ripetuta mancata concessione delle pause, protrattasi per anni, sia sufficiente a far presumere un danno significativo alla sfera psico-fisica dei dipendenti, anche in assenza di prove mediche dirette.