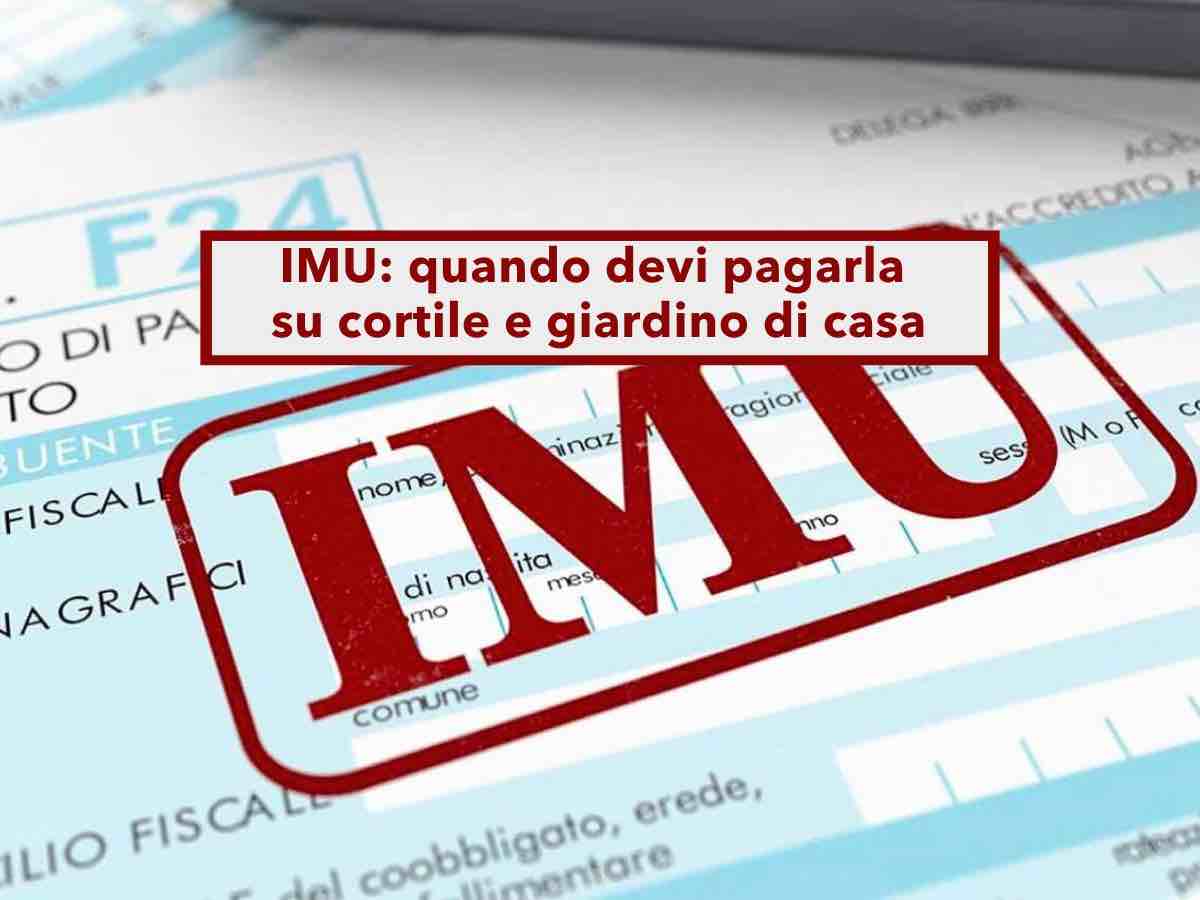Come sappiamo, l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale. Questa è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente (art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, L. 160/2019).
Le aree urbane, invece, quali ad esempio cortili o giardini contigui ad abitazioni, vanno considerate, ai fini IMU, di regola, come aree edificabili e non come aree meramente pertinenziali. Con quest’ultimo termine, nel contesto dell'IMU e della fiscalità immobiliare italiana, ci si riferisce a quelle strutture o spazi che, pur essendo distinti dall'unità immobiliare principale, sono considerati parte integrante di essa e contribuiscono al suo valore complessivo. Tipicamente, le pertinenze includono garage, cantine, e soffitte.
Per essere pertinenziali e, dunque, essere tassate in uno con il fabbricato, le stesse non devono essere suscettibili di diversa destinazione, se non attraverso una radicale trasformazione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26673, depositata il 3 ottobre 2025.
Ai fini dell’IMU, le cosiddette “aree urbane”, censite in categoria F/1 (quindi senza rendita), non possono essere equiparate né ai fabbricati né ai terreni agricoli, ma devono essere trattate come aree edificabili, se la pianificazione urbanistica ne consente l’edificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali).
Pertanto:
Le aree urbane, invece, quali ad esempio cortili o giardini contigui ad abitazioni, vanno considerate, ai fini IMU, di regola, come aree edificabili e non come aree meramente pertinenziali. Con quest’ultimo termine, nel contesto dell'IMU e della fiscalità immobiliare italiana, ci si riferisce a quelle strutture o spazi che, pur essendo distinti dall'unità immobiliare principale, sono considerati parte integrante di essa e contribuiscono al suo valore complessivo. Tipicamente, le pertinenze includono garage, cantine, e soffitte.
Per essere pertinenziali e, dunque, essere tassate in uno con il fabbricato, le stesse non devono essere suscettibili di diversa destinazione, se non attraverso una radicale trasformazione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26673, depositata il 3 ottobre 2025.
Ai fini dell’IMU, le cosiddette “aree urbane”, censite in categoria F/1 (quindi senza rendita), non possono essere equiparate né ai fabbricati né ai terreni agricoli, ma devono essere trattate come aree edificabili, se la pianificazione urbanistica ne consente l’edificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali).
Pertanto:
- l’assenza di rendita catastale non equivale a esenzione da IMU;
- conta la destinazione urbanistica, e non il classamento catastale in sé;
- la base imponibile per l’IMU deve essere calcolata sulla base del valore venale dell’area, come determinato dal mercato, in funzione dell’edificabilità.
La Cassazione ha, inoltre, precisato che l’eventuale natura pertinenziale di un’area rispetto a un altro immobile non può essere presunta, ma deve essere concretamente e rigorosamente dimostrata.
Ma la legge prevede esenzioni dal pagamento dell’IMU?
Può accadere che anziani non più autosufficienti e disabili aventi necessità di cura e assistenza continuino ad essere ricoverati in casa di riposo, lasciando così inutilizzato l'immobile in cui vivevano. Immobile che, in origine, era per l'appunto adibito ad abitazione principale. La questione è stata affrontata dalla medesima L. 160/2019, all'art. 1, comma 74, laddove si prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU, su decisione del singolo Comune, qualora l'unità immobiliare sia posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nel caso di più unità immobiliari, l'esenzione trova applicazione per una sola di esse.
Riepilogando, i passaggi fondamentali al fine di ottenere l'esenzione sono i seguenti:
- l'esenzione può essere applicata solo se prevista da delibera del Comune. È, quindi, fondamentale controllare le delibere del Comune di appartenenza, e questo si può fare sia sul sito del Ministero dell'Economia che su quello del proprio Comune: bisogna, cioè, verificare che l'assimilazione ad abitazione principale sia prevista dall'atto, altrimenti l'esenzione non spetta in nessun caso;
- la residenza dell'anziano/disabile deve essere stata trasferita nella casa di riposo in cui dimora;
- l'immobile in questione non dev'essere stato affittato a terzi;
- se l'anziano/disabile è proprietario di più immobili, l'esenzione è applicabile solo per una unità immobiliare, mentre sulle altre l'IMU è dovuta.
E cosa succede nel caso di due coniugi, entrambi non autosufficienti, aventi residenza diversa?
Uno dei profili più controversi, nella disciplina dell'IMU, era quello concernente la definizione di abitazione principale e i requisiti per l'esenzione. In precedenza, per beneficiare dell'agevolazione, la normativa e la giurisprudenza richiedevano che l'intero nucleo familiare del proprietario avesse sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nello stesso immobile.
Ad esempio, se i coniugi avevano residenze e dimore separate in due immobili diversi, situati nello stesso Comune, l'esenzione IMU poteva applicarsi solo a una delle due abitazioni.
Successivamente, in materia è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole dell'esenzione IMU per l'abitazione principale. La Consulta ha infatti stabilito che, ai fini dell'esenzione, per “abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
La Corte Costituzionale ha, quindi, contestato l'assunto che prevedeva l'agevolazione IMU solo nel caso in cui l'immobile posseduto venisse utilizzato come abitazione principale di tutto il nucleo familiare. Dopo la sentenza, pertanto, i coniugi che risiedono e hanno dimora abituale in due differenti immobili hanno diritto entrambi all'esenzione IMU, e questo a prescindere dal Comune in cui detti immobili si trovano.
La decisione della Corte Costituzionale di qualche anno fa è stata confermata, più di recente, anche dai giudici della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 4292/2025.